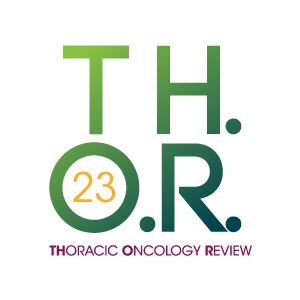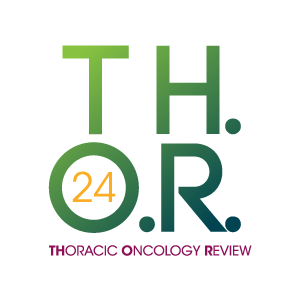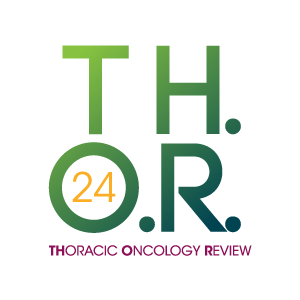Il carcinoma polmonare rimane una delle più rilevanti patologie a impatto sociale e sanitario dei paesi sviluppati, rappresentando una significativa causa di morbilità e la prima causa di mortalità in molti paesi, particolarmente nel sesso maschile In Italia il numero di nuovi casi per anno si aggira intorno ai 35-40/100.000 abitanti, con un tasso di mortalità di 81/100.000 nei maschi e 12/100.000 nelle femmine
Il trattamento del carcinoma polmonare sta subendo un cambiamento profondo. Si è passati da un’era in cui la chemioterapia era l’unica arma a nostra disposizione ad oggi, dove differenti farmaci a bersaglio molecolare e nuovi farmaci immunoterapici hanno già sostanzialmente modificato le aspettative di vita di molti pazienti. La caratterizzazione molecolare ha consentito di identificare sottogruppi di neoplasie per le quali esistono trattamenti specifici.
L’importanza di studiare biomarcatori a scopo prognostico e/o predittivo comporta la necessità di un maggiore coinvolgimento di figure che rivestono un ruolo essenziale nell’iter diagnostico del carcinoma polmonare. Per meglio identificare quali pazienti possano beneficiare di uno specifico trattamento, diventa pertanto indispensabile una stretta collaborazione fra oncologo ed anatomopatologo oltre che con lo pneumologo ed il radiologo interventista.
Molti progressi si sono delineati in oncologia polmonare in riferimento alle terapie a bersaglio molecolare, già con l’intento di superare le resistenze a vie di trasmissione del segnale più conosciute, sfruttandone altre ancora da definire.
Anche le metodiche di valutazione della risposta a tali trattamenti, non riscontrando nella radiologia tradizionale un modo adeguato di determinazione di efficacia, stanno cercando nuovi approcci sfruttando tecniche di bio-imaging.
Nel corso degli ultimi anni poi, lo scenario di riferimento del trattamento del NSCLC è profondamente cambiato. La ricerca ha dimostrato che diversi pathways molecolari svolgono un ruolo importante nella crescita tumorale: EGFR, KRAS, ALK, BRAF, ROS1, HER2 ecc. L’intervento su una o più di queste vie con diverse molecole può incidere sulla sopravvivenza di un considerevole gruppo di pazienti.
Diversi studi clinici hanno dimostrato che pazienti con mutazioni attivanti dell’EGFR rispondono in maniera ottimale al trattamento con farmaci inibitori dell’attività tirosino-chinasi del recettore. La disponibilità di diverse molecole in questo setting e l’affacciarsi di altre (ancora non nella pratica clinica) pone la problematica del corretto impiego e algoritmo ottimale dei vari farmaci nella storia di malattia del paziente.
Nel breve volgere di circa 15 anni abbiamo potuto utilizzare tre diverse generazioni di farmaci anti-EGFR e gli inibitori di terza generazione si sono dimostrati significativamente superiori a quelli di prima e seconda generazione, sia nel trattamento della malattia in stadio avanzato, che più di recente, nel trattamento della malattia in stadio precoce.
II NSCLC localmente avanzato (stadio III), rappresenta un gruppo disomogeneo in relazione alle scelte terapeutiche da intraprendere, soprattutto per quanto riguarda l’entità del coinvolgimento dei linfonodi loco-regionali (coinvolgimento dei linfonodi mediastinici e/o sottocarenali ipsilaterali N2). II trattamento deve comunque considerare diversi tipi di strategie terapeutiche e tutte le possibili opzioni di trattamento.
Nel contesto della malattia localmente avanzata il ruolo dell’immunoterapia si è prepotentemente affermato, in un segmento di pazienti ove non si era registrati progressi terapeutici nel corso degli ultimi venti anni nonostante un intenso impegno della ricerca clinica nel migliorare le aspettative di vita di questi pazienti In tale mutevole contesto appare esserci considerevoli necessità che volgono lo sguardo ad una collaborazione con altri specialisti (pneumologi, radiologi interventisti, anatomo-patologi, biologi molecolari, radioterapisti, endocrinologi, immunologi, radiologi...) a sottolineare come in oncologia toracica la multidisciplinarietà sia fondamentale.